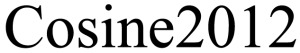Intervento di Mons. Francesco Savino
Abbazia di Montecassino (Frosinone)
La speranza, in greco elpis, nel mondo antico era una presenza enigmatica e densa di sfumature. Nel mito di Pandora, narrato da Esiodo, la speranza rimane imprigionata nel vaso dopo che i mali si sono riversati sul mondo. Alcuni la intendevano come un dono estremo, un sigillo silenzioso che impedisce all’uomo di precipitare nella disperazione assoluta. Altri, invece, la vedevano come un inganno dolce, un velo che distoglie dal coraggio di affrontare la cruda verità della vita. È opportuno precisare, però, che questa interpretazione meriterebbe uno studio ulteriore e più profondo, perché il valore della elpis in Esiodo resta un enigma affascinante, che ancora oggi provoca discussioni tra filosofi, teologi e studiosi.
Nel pensiero greco, parlare di speranza (elpis) significa addentrarsi in un orizzonte dove l’uomo (anthropos) è percepito come fragile, finito, ma sempre proteso verso l’oltre. L’anthropos, nella visione ellenica, si trova costantemente sospeso tra limite e possibilità, tra la potenza invincibile della necessità (anánke) e il desiderio di superare sé stesso. Anánke, la necessità inesorabile, rappresenta quella forza impersonale e inflessibile che avvolge ogni creatura in un intreccio indissolubile di vincoli. Di fronte a questa potenza, la spera a appare come un atto di sfida, un gesto che osa infrangere il confine del destino, un tentativo impavido di strappare spazi di libertà nell’imprevedibile.
Accanto ad anánke, il daimon riveste un ruolo fondamentale. Non si tratta di un demone nel senso moderno, ma di un principio interiore, un soffio segreto che abita l’uomo, lo orienta, lo ispira e lo accompagna verso il compimento autentico della sua vocazione. È un genio tutelare, un frammento divino che custodisce l’irripetibile unicità di ciascuna vita. Platone, nel Simposio, lo descrive come un ponte tra l’umano e il divino, una voce interiore che ci chiama a diventare ciò che siamo destinati a essere.
La speranza, dunque, non si riduce a un ottimismo ingenuo, ma diventa un ascolto vigile e profondo di questo daimon, un dialogo coraggioso con la parte più vera di noi. Significa dimorare nel proprio desiderio senza evitarlo, accogliendo la tensione tra ciò che siamo e ciò che siamo chiamati a diventare. Il daimon non promette una vita facile, ma una vita vera, autentica, fedele alla propria essenza più intima.
Sperare, in questo senso, è un atto creativo, un affidarsi fiducioso a quella voce che ci spinge oltre, che ci invita a trasformare le paure in possibilità, le ferite in aperture verso nuove forme di significato.
Il daimon ci chiede di non accontentarci di esistenze piccole, di non barattare la nostra profondità con la sicurezza apparente di vite addomesticate e anestetizzate. La speranza si fa allora coraggio: il coraggio di cadere, di fallire, di rialzarsi e ripartire, di restare fedeli a quel battito segreto che ci anima, anche quando tutto attorno sembra esigere uniformità, silenzio e rassegnazione.
In ultima analisi, la speranza che nasce dal daimon non è evasione, ma una chiamata radicale: ci spinge a diventare opere d’arte viventi, come suggeriva Nietzsche, a plasmare la nostra vita come un artista plasma la sua creazione. Non è un rifugio dalla realtà, ma un’immersione totale nella verità più profonda, quella che ci rende irripetibili e, allo stesso tempo, ci apre all’incontro autentico con l’altro.
Accanto a questa dimensione interiore, i Greci collocavano il concetto di ethos (ἦθος), che in origine significava “luogo dell’abitare”, prima di indicare il carattere morale. L’ethos non è un insieme di regole esterne, ma la trama profonda che sostiene e guida il nostro modo di stare al mondo. La speranza, intesa come elpis, diventa parte integrante dell’ethos: non una semplice emozione fugace, ma un orientamento costante, una postura esistenziale che plasma la nostra quotidianità.
Sperare significa accettare la vita come uno spazio in cui si intrecciano necessità e libertà, destino e scelta, ricordo e sogno. L’ethos della speranza è un modo di abitare la storia e il tempo con apertura, di costruire legami autentici, di considerare la comunità come un luogo di cura, di attesa condivisa, di progettualità condivisa.
Platone assegnava alla speranza un ruolo centrale: essa alimentava il desiderio del bene e orientava l’anima verso l’Idea suprema. Seneca, con la lucidità severa dello stoico, metteva in guardia contro l’attesa di ciò che non dipende da noi, suggerendo una serenità fondata sulla ragione e sull’autosufficienza interiore. Già allora, la speranza era percepita come forza ambivalente, sospesa tra redenzione e illusione, tra slancio vitale e pericolo di inganno.
Con il cristianesimo, la speranza assume un volto nuovo, potremmo dire trasfigurato. Non è più un’attesa incerta né un rifugio psicologico, ma diventa una virtù teologale, sorella della fede e della carità. La speranza cristiana è un’ancora proiettata oltre il velo della storia, un affidamento radicale alla fedeltà di Dio. La Lettera agli Ebrei ci ricorda: «Abbiamo questa speranza come un’ancora sicura e salda, che penetra fino all’interno del velo» (Eb 6,19).
In Cristo crocifisso e risorto, la speranza si incarna, entra nel tempo, si fa carne e compagna di cammino. Non è un concetto astratto, ma un percorso fatto di passi, di scelte quotidiane, di gesti di vicinanza e di cura. È un verbo che vibra nell’immediato, non un nome freddo e lontano. Sperare significa continuare a seminare anche quando il terreno sembra sterile; significa scegliere di restare, di non voltarsi, di non lasciarsi schiacciare dalla rassegnazione.
Viviamo oggi un tempo segnato da paure, frammentazioni, diffidenze. Byung-Chul Han parla di una società della stanchezza, un’umanità esausta, ripiegata su sé stessa, sempre più incapace di concepire un futuro comune. Il rischio è quello di ridurre la speranza a un prodotto emotivo, un oggetto di consumo rapido per sopportare la fatica di vivere, svuotandola della sua forza comunitaria e trascendente.
Ma la speranza autentica non è un ottimismo superficiale né un artifizio spirituale. È un atto mite di resistenza, un coraggio gentile che sfida il disincanto e il cinismo. È lo sguardo che vede nell’altro un volto, non una minaccia; un fratello, non un avversario.
In questa prospettiva, la riflessione di Ernst Bloch conserva una potenza sorprendente. Nel suo Il principio speranza, Bloch afferma che la speranza non è un’attesa passiva, ma un movimento creativo verso ciò che ancora non è, ma può diventare. Sperare, per lui, significa abitare il “non-ancora”, custodire la brace di un’umanità in gestazione, che desidera la propria fioritura. La speranza diventa così forza motrice, energia che trasforma il singolo e la collettività, spingendo a costruire, fin da ora, un mondo più giusto e fraterno.
Come Chiesa, siamo chiamati a “organizzare la speranza”, come diceva don Tonino Bello. Non può rimanere un concetto astratto: deve farsi pane condiviso, ascolto premuroso, educazione alla gratuità, cura per i più fragili. Ogni gesto di tenerezza, ogni abbraccio che consola, ogni parola che solleva è già frammento vivo di questa speranza incarnata.
Il nostro tempo ha bisogno urgente di testimoni veri, non di predicatori che urlano. Servono uomini e donne che dicano con la vita che la notte non avrà mai l’ultima parola. Che la luce, anche se piccola, resta sempre più forte del buio più profondo.
Ecco perché, oggi, parlare di speranza significa parlare di responsabilità. Non è un’emozione passeggera, ma una vocazione da vivere giorno dopo giorno. È la fedeltà tenace al sogno di Dio sull’uomo e sulla storia.
Profetiche le parole di san Paolo ai Romani: «Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo» (Rm 15,13).
Sia questa, per tutti noi, la benedizione più grande: diventare artigiani di speranza, tessitori di futuro, costruttori di ponti e non di muri. Che ognuno possa essere, nel silenzio delle sue giornate, un piccolo frammento di luce capace di squarciare l’oscurità dei nostri tempi