|
|
|
|
|
|
|
|
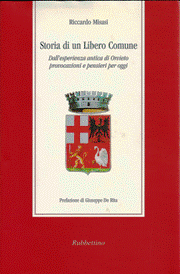
Riccardo Misasi
Storia di un Libero Comune
Rubbettino Editore
| Condividi | Tweet |
Come chi possiede il genio della perspicacia e della riflessione, fra l’altro mediata da cultura solida e vissuta, Riccardo Misasi, nella ultima parte del suo libro “ Storia di un libero Comune – Dall’esperienza antica di Orvieto – provocazioni e pensieri di oggi” si domanda sull’espansione dello Stato Centrale: il riformismo, il suo esaurimento e la crisi della culture politiche, per poi proseguire sui temi che sembrano essere stati approfonditi non già nel 1999, ma oggi a 13 anni di distanza e quindi quesiti attualissimi che,
se riformulati, darebbero la giusta luce allo sforzo metodologico per ridefinire gli argomenti.
L’insorgenza dei particolarismi, la novità e l’importanza del fenomeno della Lega: i limiti i rischi e le ragioni. La elefantiasi della spesa pubblica, così d’attualità, la crisi del Welfare.
E poi sulla Inevitabilità ed inadeguatezza del federalismo, la comunità delle comunità, i dubbi sulla privatizzazione, Impresa e democrazia, punto cruciale della riflessione di Misasi.
Franco Petramala
I. Conquiste del Libero Comune e poi della Rivoluzione
Francese - Il diverso modello istituzionale - Lo
Stato nazionale, centrale ed accentratore - Coerenza con la
matrice illuminista - L'espansione dello Stato centrale:
il riformismo - Usuo esaurimento e la crisi delle culture
politiche.
Poche volte nella storia i protagonisti ebbero una così chiara e
quasi epica percezione dell'importanza di quanto andavano
compiendo, come la ebbero quelli della Rivoluzione Francese.
Questo diede loro a volte un'eccezionale efficacia di sintesi
oratoria. Con questa lapidaria capacità di sintesi del progetto
e dell'utopia rivoluzionari, Saint-Just pronunciò la frase:
la felicità è una idea nuova in Europa. Saint-Just, però, fu
anche colui che più si battè contro le vaghe suggestioni
federalistiche della Gironda e propugnò, anche al di sopra ed
anzi contro i partiti, l'idea della necessaria concentrazione
del Potere, meglio espressa nei suoi Fragmentes ainstitutions
republicaines.
Si comprende allora come, a contenere e rappresentare i princìpi
e le conquiste rivoluzionari, potesse benissimo servire e
venisse anzi utilizzato quello stesso involucro di un
ordinamento centrale ed accentratore che, costruito dalla
Monarchia Assoluta, fu poi ulteriormente consolidato e
naturalmente perfezionato dal Bonapartismo. C'era e se ne ebbe
chiara consapevolezza, non solo una piena compatibilità tra le
idee, le radicali innovazioni rivoluzionarie ed il modello di un
forte Stato centrale; ma c'era anche una sostanziale coerenza di
tale modello con la
matrice razionalista ed illuminista della Rivoluzione e con
l'utopia, largamente condivisa, di costruzione, finalmente nella
storia, di condizioni di felicità. (Non fu infatti il solo
Saint-Just a parlarne; ma, all'interno di discorsi molto meno
sintetici, questa parola, felicità, attraversa tutto il
periodo rivoluzionario e la si ritrova un po' dovunque sia nei
dibattiti, sia negli scritti).
Si può anzi riconoscere che questo coniugarsi dell'utopia e del
razionalismo rivoluzionari con l'idea ed il modello di un forte
Stato centrale, costituì già in nuce le premesse possibili degli
esiti, cui pervenne la successiva elaborazione culturale del
pensiero moderno con l'hegelismo ed i suoi epigoni, derivando,
direttamente dal primo, la concezione dello Stato Etico e,
dall'hegelismo di sinistra, che vi approdò con Engels e con
Marx, quella dello Stato Collettivista1.
Qui però interessa sottolineare che la fine del feudalesimo,
l'avvento della borghesia, il profondo mutamento dei rapporti di
potere, le grandi idee di libertà e di eguaglianza, tutti cioè i
fecondi risultati della Rivoluzione Francese, si sono realizzati
in Europa secondo e dentro un certo modello di ordinamento,
dando vita a quello Stato moderno che, poi, anche in Italia,
ispirò l'esito finale del Risorgimento e l'organizzazione dello
Stato Unitario nazionale.
In questo tipo di Stato la garanzia contro i rischi di
assolutismo, secondo la lezione del Montesquieu, è fornita dalla
distinzione verticale delle tre funzioni fondamentali del
medesimo Stato, articolate nei tre diversi poteri: legislativo,
esecutivo e giudiziario. Così articolato al suo interno, questo
Stato complessivamente si pone come il garante ed il tutore
esclusivo dei bisogni e degli interessi dei singoli cittadini,
componenti la Nazione. Con la sua forte amministrazione
distribuita anche perifericamente, esso è in rapporto diretto
con l'individuo; poco o nessuno spazio consente alle comunità
intermedie, alle quali non concede alcuna reale autonomia, ma
solo un certo decentramento di funzioni amministrative. Le
Comunità, le formazioni spontanee ed originarie di autonomia non
hanno, di per sé, valore. Il valore è nello Stato ed è esso che
solo può e deve assicurare l'uguale tutela dei cittadini. Ecco
perché, allora, lo Stato Unitario italiano, scaturito dal
Risorgimento, ebbe non
solo un motivo contingente, ma una ragione culturale intrinseca
che lo portò a non riconoscere autentico spazio alle autonomie.
Queste linee essenziali e portanti del modello statuale non sono
state scalfite nemmeno successivamente. La storia ha poi, e fino
ai nostri giorni, conosciuto altre straordinarie innovazioni e
grandi conquiste civili e sociali, intervenute sotto la spinta
delle forze politiche riformatrici.
Ma anche il riformismo, qualunque matrice esso avesse, non ha
cambiato il modello ed, anzi, lo ha ulteriormente rafforzato e,
per così dire, ingrandito.
Le riforme infatti hanno significato e sono venute sempre più
realizzando una grandiosa espansione della tutela dei bisogni,
allargandola via via a nuove esigenze, prima ignorate ed
escluse. Ne è derivata pertanto una notevole espansione dei
compiti dello Stato.
Questo, come si sa, limitava inizialmente il suo ruolo alla
soddisfazione di alcuni bisogni primari ed essenziali, cui
corrispondevano i compiti propri della politica estera ed
interna, dell'ordine pubblico, dell'amministrazione della
giustizia, delle grandi opere pubbliche, del prelievo fiscale
delle risorse e della loro utilizzazione. Gradualmente poi è
venuto estendendo il proprio impegno alla prestazione, anzi
anche all'organizzazione della prestazione, di tutta una serie
di grandi servizi, da quello scolastico a quello previdenziale,
a quello sanitario, a quello dell'erogazione
dell'energia, a quello dell'assistenza, sotto varie forme ed in
varie guise.
Con ciò stesso lo Stato è venuto esercitando già un'influenza
crescente nella vita economica, in quanto portatore di una forte
domanda pubblica e detentore di una rilevante offerta. Ma ha
poi, sempre più, svolto un ruolo economico diretto, sia
assumendo perfino una propria veste imprenditoriale, sia
intervenendo con politiche di incentivazione e di programmazione
dello sviluppo; sia stabilendo forme particolari di assistenza
nei momenti, e/o per i settori di crisi, con le casse
integrazioni, con i finanziamenti alle innovazioni tecnologiche
ed alla ristrutturazione
industriale, eccetera, sia dando vita ad un'ampia innovatrice
legislazione sociale del lavoro.
lutto questo non ha significato un superamento del capitalismo.
Né ha tuttavia segnato una profonda trasformazione, attraverso
il passaggio dal vecchio capitalismo, che, nell'assoluto
prevalere di una logica brutale del profitto, legittimava
l'accusa dello sfruttamento degli operai, ad un nuovo
capitalismo o neo-capitalismo, con il quale il riformismo stesso
si è posto e si pone in un rapporto intrecciato e reciproco di
causa e di effetto. Tutto l'insieme di questi risultati ha
significato un enorme progresso civile ed un generale
miglioramento delle condizioni di vita, anche se ha
quasi fatalmente comportato una corrispondente elefantiasi della
macchina amministrativa e la nascita di mastodonti burocratici,
ai quali si sono spesso collegate lentezze ed inefficienze che,
oggi, sono particolarmente avvertiti. Tuttavia la comprensibile
ed anzi giusta esigenza di revisioni incisive, che assicurino
snellimento, efficienza e rapidità, non inficia il valore delle
grandi conquiste del riformismo, né può rimettere in discussione
i risultati raggiunti con quella espansione della tutela dei
bisogni, che è poi la sostanza di quello che si chiama
Welfare State.
Ciò va detto e ribadito, ma bisogna anche aver coscienza che
tutto questo è ormai passato, sta dietro le nostre spalle, è un
risultato già raggiunto.
Nel quale, probabilmente, si è ormai esaurita la forza
propulsiva del riformismo tradizionale. Bisogna difenderlo e
conservarlo. Ciò è necessario e tuttavia non sufficiente:
nessuna prospettiva si apre, nessun futuro si costruisce solo
conservando il passato.
L'esaurimento del vecchio riformismo inoltre si inscrive dentro,
ed anzi definitivamente esprime, una più generale crisi delle
culture politiche tradizionali.
E in crisi quella del collettivismo, anch'essa consumata dalla
storia, e francamente appare improbabile una sua effettiva
riproponibilità, mirata a raggiungere cioè, e capace di
ottenere, il consenso maggioritario necessario a realizzarne il
progetto. Altrettanto inadeguata appare l'idea di chi ritiene
eventualmente vincente e cariche di futuro le culture del
neo-capitalismo e del liberalismo. 11 primo, come si è appena
detto, è in gran parte l'altra faccia del riformismo e, come
questo, nei propri lineamenti essenziali, costituisce un dato
acquisito o, se si vuole, un punto di
partenza, che, tuttavia, per ciò stesso, non può essere anche un
punto di arrivo. Il liberalismo, nei suoi valori portanti,
rappresenta un patrimonio ineludibile ed alto, ma pressoché
comune, generalmente condiviso.
Esso va sempre conservato e difeso, specie quando ritornano le
insidie, che sempre affiorano nei momenti di inquietudine, di
confusione, di sbandamento, che la storia purtroppo conosce. Ma
questo significa che il liberalismo è un grande cuore antico
da salvaguardare, non è e non può essere il nuovo da
inventare. Che resta allora? Sembra proprio di vivere uno di
quei diffìcili momenti di transizione nei quali l'assenza di
idee nuove, di nuove ed adeguate culture politiche, e
conseguentemente di autentiche tensioni morali, alimenta un
clima di confusione, di incertezza, di insicurezza, nel quale
facilmente emergono spinte irrazionali, tendenze perfino
violente, bagliori, a volte cupi, di antiche suggestioni,
nostalgie, e più che nostalgie, di improponibili ritorni
indietro. Ciò in Italia e, forse, ancor più in Europa. Di fronte
a ciò la difesa delle conquiste realizzate è una necessità; ma
non basta.
Quando mancano culture politiche nuove e, quasi per forza di
inerzia, sopravvivono stancamente le vecchie, gii interessi, le
domande, le
aspirazioni presenti nella società ed emergenti dalle sue
trasformazioni, vengono a mancare di un punto di riferimento,
perché manca la capacità di leggere e di interpretare i fenomeni
sociali, il loro movimento, la diversità di istanze che lo
animano. Manca l'ascolto del mormorio della storia. Manca
l'attenzione ed il rispetto delle diversità ed insieme la forza
unificante di una sintesi più alta, di un progetto politico
complessivo, in cui tutte possano in qualche modo riconoscersi.
Non a caso i movimenti che hanno rivelato vivacità ed anche
vitalità, negli ultimi decenni, sono stati quelli monotematici,
come tipicamente sono stati i movimenti ambientalisti. Movimenti
portatori più di una denuncia, che non di una proposta o,
meglio, portatori solo di proposte parziali. Non se ne può
negare l'importanza; se ne può tuttavia cogliere la limitatezza.
Ma l'assenza di risposte politiche complessive ed adeguate
determina inevitabilmente, a poco a poco, una condizione
crescente di insoddisfazione e di malessere. Privi della
necessaria mediazione politica, gli interessi tendono a
ripiegare su se stessi e ad arroccarsi nella difesa
egoistica,corporativa o localistica del proprio partìculare.
Si attenua fin quasi a scomparire, la consapevolezza delle
possibili ragioni di unità e di solidarietà.
Nascono e si alimentano spinte disgregatrici. Già di per sé,
dunque, la crisi delle culture politiche diventa ragione di
crisi degli stessi assetti istituzionali precedenti.
II. Il malessere in Italia ed in Europa - La trasformazione del
quadro internazionale
- l'insorgenza dei particolarismi - La novità e l'importanza
del fenomeno della Lega - Limiti, rischi e ragioni - La crisi
del modello dello Stato nazionale moderno è irreversibile? -
Elefantiasi della spesa pubblica - La perdita delle identità
nell'attuale Welfare State – Necessità del riordino dello
stesso e delle riforme istituzionali.
Contribuiscono, però, a generare la condizione di malessere,
anche altri fattori che si intrecciano con la crisi culturale,
in un reciproco rapporto di interdipendenza. Innanzi tutto c'è
da considerare le conseguenze indotte dalle radicali modifiche
intervenute nel quadro internazionale.
La caduta della diga o del muro, che divideva l'Occidente dalla
realtà della Unione Sovietica e del Comunismo, è stata
certamente un fatto straordinariamente positivo, ma altrettanto
straordinariamente carico di effetti pressoché sconvolgenti.
Essa infatti ha significato anche la fine di un determinato
equilibrio, certo precario, ma in qualche modo definito,
conosciuto e si vorrebbe dire paradossalmente rassicurante.
Quel muro, per quasi cinquant'anni, almeno per l'Europa
occidentale, era stato sì una barriera, ma anche una difesa e
quasi una protezione.
La sua caduta ha determinato ad Est, con il crollo della
ideologia, pur sempre unificante, del Comunismo, il rapido
disgregarsi del vecchio assetto, la nascita di nuovi Stati
indipendenti, l'insorgere delle varie etnie, l'esplodere di
antichi e non sopiti contrasti, diversità, perfino odi, quasi
razziali, che hanno, come nell'ex Jugoslavia, improvvisamente
fatto riemergere violenze, ferocie e barbarie da primo Medioevo.
Ad Ovest quella caduta ha determinato qualcosa di diverso, ma
non del tutto dissimile. Si è diffusa l'impressione di una
qualche incertezza, di una qualche insicurezza. È affiorato un
timore nuovo e, forse, insieme, antico, di possibili incombenti
minacce alla propria raggiunta condizione di relativa
tranquillità e benessere. Forse la stessa riunifìcazione della
Germania ha stimolato antichi sospetti per il ricostituirsi di
una grande, compatta potenza centrale. Ancor di più,
probabilmente, ha alimentato quel timore e quella impressione di
minaccia la mobilità della situazione più ad Est. L'ansia cioè,
di tutte le popolazioni, dei Paesi dell'Est europeo, di muoversi
verso il benessere, di conoscerlo finalmente e di parteciparvi,
sommata alla crescente analoga tendenza delle popolazioni del
Sud ed, in specie, del Mediterraneo. Si potrebbe quasi dire che
è come se fosse riaffiorata,
quasi nel subconscio, una paura atavica, una sorta di rigurgito
dell'ancestrale ed angosciosa memoria storica di antiche
massicce migrazioni di popoli, di invasioni barbariche e
saracene, da Est e da Sud.
È abbastanza comprensibile allora come siano potute insorgere
spinte, tendenze, addirittura movimenti di sapore xenofobo, se
non del tutto razzistico, e come si sia ulteriormente accentuato
quell'atteggiamento di arroccamento, di immediata ed istintiva
difesa della propria condizione e dei propri circoscritti
interessi. Altrettanto spiegabile è la conseguente perdita delle
ragioni del legame e della solidarietà con gli altri, anche con
i vicini, considerati anch'essi estranei se non addirittura
nemici: quasi
palla di piombo al piede o motivo di maggior debolezza, o causa
di spreco di risorse, che si ritengono invece necessarie a
consolidare e a difendere la propria condizione.
Non è casuale infatti, che l'inquietudine, l'insofferenza,
l'emergere di spinte disgregatrici, si siano manifestati proprio
nelle zone di maggior benessere, dove emerge anche una qualche
tendenza a ritornare indietro nella storia. La ed. Padania
somiglia troppo al Lombardo-Veneto, per non dare questa
impressione. Ma, forse, a ben guardare, questo percorso a
ritroso va ben oltre. È un ergersi di mura e di torri merlate,
un bandire crociate e, perciò, anche qui, in Occidente, un
qualche ritorno di Medioevo.
Il fenomeno di gran lunga più nuovo e, anzi, l'unico veramente
nuovo, la spia, comunque, che maggiormente illumina ed in buona
parte esprime, questa condizione di malessere, di inquietudine e
di insoddisfazione, è stato, in Italia, la Lega. Ma per quanto
possa apparire strano, la Lega, senza né perdere il consenso, né
cadere nel ridicolo, in tante sue manifestazioni esteriori, si è
proprio vestita di Medioevo. Pontida, i giuramenti, il
Carroccio, le calzemaglie, gli elmi, gli scudi, se sono stati
una manifestazione di superficie, non hanno tuttavia costituito
un semplice fatto di folklore. Sono stati il simbolo visibile di
una reazione istintiva, immediata e medievale ad una medievale
paura.
Sotto le manifestazioni esteriori però, c'è probabilmente un
certo qual rifiuto o almeno una qualche avvertenza dei limiti e
della inadeguatezza dello Stato moderno, del suo modello, così
come si è venuto costruendo ed espandendo con le conquiste del
riformismo.
In questo senso la Lega ha rappresentato il fenomeno più
autentico ed interessante, per denunciare e insieme cogliere le
ragioni intime della condizione di crisi che si sta vivendo, e
l'intreccio di cause interne ed esterne che l'hanno determinata:
l'esaurirsi delle culture politiche tradizionali e le radicali
trasformazioni del contesto internazionale. Il fenomeno Lega
perciò andava probabilmente ed andrebbe letto con molta più
attenzione di quanto non ne segnino il semplice ed aprioristico
rifiuto, la contrapposizione netta 0, viceversa, l'inseguimento
acritico sul terreno delle rivendicazioni espresse.
Fermandosi alle manifestazioni di superficie si potrebbe anche
evidenziare, ed in qualche modo con qualche strana notizia di
stampa lo si è, recentemente, tentato, un netto contrasto tra i
richiami storici, cui la Lega si è rifatta e le sue concrete
suggestioni politiche. Pontida, il Carroccio, l'antica "Lega
lombarda" nacquero e si caratterizzarono, come si è visto,
contro l'Impero tedesco ed il Barbarossa, saldandosi invece
idealmente con Roma ed il papato. La posizione della Lega
sembrerebbe viceversa quasi esattamente opposta: rifiuto
polemico di Roma ed aggancio con l'impero, cioè con la realtà
forte dell'Europa centrale, di cui si ritiene di poter
costituire una delle zone economicamente più vitali e floride,
rispetto alla quale il resto dell'Italia verrebbe considerato
come un peso, una ragione di ritardo e di debolezza, una realtà,
comunque, diversa ed eterogenea. In questo senso si potrebbe
perfino dire che la Lega sarebbe oggi ghibellina, stimolando
immediatamente, di converso, la consapevolezza della necessità
di riproporre ed attualizzare l'antico spirito guelfo di Alberto
di Glissano. Sarebbe però una notazione superficiale ed
impropria. Eventuali interessi particolari, che nutrissero
calcoli e disegni di quel tipo avrebbero poco a che fare con la
natura intrinseca del fenomeno, che è tutta nel rifiuto dello
Stato centrale e centralizzato e nella attenzione e difesa verso
e peculiarità e l'identità propria di comunità e
territori.
Perciò al di là del facile gioco di immagini e di parole, è
diffìcile negare il carattere popolare del fenomeno ed il
significativo radicamento della Lega nella realtà di importanti
e vaste zone. Per alcuni aspetti essa avrebbe potuto
configurarsi e, chissà, forse lo potrebbe ancora, come una forza
popolare di tipo bavarese o, per altro verso, catalano. Non si
può, allora, non fare i conti con questa novità reale. Del
resto, già sul terreno della unificazione monetaria dell'Europa,
l'esistenza stessa della Lega ha rappresentato oggettivamente
una spinta forte per superare resistenze, difficoltà,
abitudini e fare accettare, dove forse, altrimenti, sarebbe
stato meno facile, politiche di maggior rigore per non mancare a
quell'appuntamento con l'Europa, rispetto al quale un fallimento
od anche solo un rinvio avrebbe acquistato, o è parso che
avrebbe acquistato, il significato di una minaccia grave alla
stessa tenuta unitaria dell'Italia.
Certo ogni fatto politico che esprime un malessere autentico ed
insorge per contestare l'assetto preesistente, ha in sé il
rischio di possibili degenerazioni ed esasperazioni. Per certi
aspetti, è stato spesso cosi nella storia. Il massimalismo,
antico e ritornante male storico del socialismo italiano,
tuttavia, non inficiava l'importanza e la ragion d'essere di
quel movimento. Non si può rispondere al nuovo che emerge, anche
se confusamente, con l'indifferenza, né con l'illusione di
isolarlo e circoscriverlo,
né con la repressione. Tanto più quando il fenomeno nasce da una
crisi che accomuna e riguarda tutti. Nella consapevolezza di
questa comune condizione è piuttosto da chiedersi se
l'indicazione indipendentista che, quasi istintivamente il
leghismo porta avanti, corrisponda davvero alle ragioni
profonde, alle cause di quel malessere, dal quale il fenomeno
leghista ha avuto origine ed alimento e del quale è, per molti
aspetti, significativa e forse principale espressione.
Il dubbio appare del tutto legittimo. Ammesso, in via di pura
ipotesi, che sia realistico e possibile circoscrivere a difesa,
e delimitare, un pezzo imporrante di territorio, che si ritiene
economicamente omogeneo e che, solo, in questa omogeneità
economica, troverebbe il suo ubi consistam, è assai
difficile pensare che ciò basterebbe ad esaurire e risolvere le
cause vere della crisi e della stessa insoddisfazione.
Prima o poi, e più prima che poi, probabilmente, esse
riapparirebbero anche all'interno di un nuovo, più piccolo
Stato, per l'evidente ragione che il distacco di un pezzo di
territorio e la nascita di un nuovo Stato, di per sé, non
risolvono la crisi delle culture politiche, né ne inventano una
nuova e ben difficilmente corrispondono alle questioni derivanti
dalle radicali modifiche del quadro internazionale, e dal senso
più profondo della deriva storica, che esse sottintendono.
Questa, se segna una domanda di attenzione verso ogni
peculiarità e diversità, sembra indicare altresì la direzione,
ed insieme l'esigenza, di un nuovo e diverso ordine mondiale, di
una nuova, diversa e più stringente solidarietà tra gli uomini
di tutti i Paesi e di tutti i Continenti, di un nuovo e diverso
equilibrio, che superi, invece di consolidare, chiusure ed
egoismi nazionali.
Se questa fosse l'onda lunga che muove nel profondo la storia
degli uomini del nostro tempo, essa certamente sarebbe
destinata, come sempre accade, ad incontrare resistenze,
ostacoli, contrasti anche duri; ma, sia
pure attraverso fasi alterne e momenti di confusione, di
incertezza, forse di paura, alla fine travolgerebbe le
resistenze ed imporrebbe, ove non li avesse già messi fin d'ora,
in qualche modo, in crisi, il superamento degli assetti e dei
modelli istituzionali preesistenti. Si pone allora un
intetrogativo che è poi l'oggetto centtale di queste tiflessioni
conclusive.
Vien fatto da demandarsi, cioè, se non sussistano ormai rutti i
segni di una crisi irreversibile dell'idea stessa e del modello
dello Stato nazionale moderno, e se quell'intreccio, già prima
rilevato, che ha caratterizzato il rapporto tra la nascita, lo
sviluppo e l'espansione dello Stato moderno, e le culture
politiche tradizionali, non implichi, con l'esaurimento di
queste, la definitiva messa in discussione anche di quello.
Se così fosse, e se quella sopra indicata fosse la deriva della
storia, il problema, lungi dal contrastare tale deriva, sarebbe
semmai quello di costruire un progetto e proporre una cultura
politica nuova, capace di coniugare l'inarrestabile spinta verso
l'internazionalizzazione, con l'altrettanto forte e legittima
esigenza di attenzione verso ogni diversità e, quindi verso ogni
comunità ed autonomia.
Sta di fatto che, ad alimentare il disagio ed il malessere,
concorrono almeno due elementi del tutto intrinseci al tipo di
ordinamento proprio dello Stato centrale ed accentratore. Il
primo è costituito dalla elefantiasi della spesa, cui consegue
spesso la crescita abnorme del debito pubblico.
Il secondo dalla perdita dell'identità della persona,
all'interno di un modello centralizzato ed uniformatore nella
tutela dei bisogni.
Sotto il primo profilo, è evidente che l'imponente espansione
dei compiti dello Stato non poteva non comportare una
corrispondente crescita della spesa pubblica.
D'altra parte, le profonde modifiche intervenute nel costume, il
progresso scientifico e gli stessi positivi effetti di una più
ampia e diffusa tutela della salute, hanno introdotto grandi
trasformazioni negli andamenti demografici, sia alla base, con
la diminuzione delle nascite, sia al vertice, con il sensibile
prolungamento della vita media. Tutto ciò ha significativamente
accresciuto il numero dei beneficiari sia della previdenza, sia
dell'assistenza, specie sanitaria, e quindi le ragioni della
spesa.
Di converso, anche in virtù di grandi innovazioni tecnologiche,
si è spesso avuto l'effetto di una restrizione della base
lavorativa e contributiva del sistema, ed, in ogni caso, si è
sensibilmente modificato, se non invertito, il rapporto tra
contribuenti e beneficiari.
Gradualmente ed in modo via via crescente, allora, lo scompenso,
tra le risorse introitate dallo Stato, attraverso il Fisco ed i
contributi, e la mole della spesa, ha fatalmente comportato
l'aumento crescente del debito pubblico.
Questo a sua volta, ha aggiunto un ulteriore ed automatica
ragione di espansione e della spesa e di se stesso, per il
meccanismo degli interessi, che ne costituiscono il costo, e che
specie nel lungo periodo di inflazione alta, hanno rappresentato
un moltiplicatore di enorme portata.
Già tutto questo, di per sé ha contribuito a diffondere un senso
di alcatorietà, di insicurezza, di inquietudine, accrescendo
ulteriormente, specie presso gli interessi più forti e nelle
zone più benestanti, il malessere e la insoddisfazione.
Bisogna poi aggiungere che se la lunga fase di alta inflazione
ha avuto prevalenti cause esterne, tuttavia, ha provocato gravi
conseguenze interne, determinando una condizione generale, e
quasi un'abitudine, con le quali si è convissuti a lungo2.
Essa si è accompagnata o, meglio, si è caratterizzata con una
serie di eventi di straordinaria portata e ripercussione: la
denuncia degli accordi di Bretton Woods; la guerra del Kippur;
l'aumento del prezzo delle materie prime ed in particolare del
petrolio; la nascita e lo sviluppo, nei Paesi produttori, delle
industrie di prima lavorazione delle materie prime;
l'affacciarsi sul mercato mondiale, specie dall'Asia, accanto al
Giappone, di altri Paesi industrializzati fortemente
competitivi; l'accentuatsi, anche per l'insieme di questi
fattori, di quel processo di internazionaliz-
zazione dell'economia e quindi di interdipendenza che, già di
per sé, spiega come la pressione inflazionistica diffìcilmente
possa esser limitata entro confini nazionali.
Tutti questi fatti hanno profondamente modificato condizioni ed
equilibri precedenti; travolto precedenti previsioni; cambiato i
rapporti tra Paesi produttori e Paesi consumatori e/o
trasformatori di materie prime; provocato reazioni,
comportamenti, scelte all'interno di ciascun Paese, che, a loro
volta hanno profondamente modificato assetti, progetti,
andamenti e profezie antecedenti.
Basti pensare alle conseguenze che si sono avute in Italia, la
cui industria era ed è essenzialmente trasformatrice e,
particolarmente, agli effetti dirompenti che si sono qui avuti
sulla ed. politica meridionalistica3.
Senza approfondire in questa sede un discorso importante ma in
buona parte estraeo ed ultroneo rispetto alle riflessioni che
interessano, è sufficiente rilevare che quel distacco del
Mezzogiorno, o, meglio delle zone più depresse del Mezzogiorno,
dal resto del Paese, che sul finire degli anni '60 era sembrato
attenuarsi, non solo è restato, ma per certi aspetti è venuto
aggravandosi mentre è cresciuta, e divenuta pressoché
drammatica, una condizione troppo diffusa di disoccupazione,
specie giovanile. Il problema della disoccupazione, peraltro, è
ora emerso, anche al di fuori del Mezzogiorno, in Italia ed in
Europa.
Esso si somma con l'altrettanto inevitabile riordino del
Welfare State e ciò nel mentre si verificano le richiamate
tendenze localistiche, delle quali, del resto la fine di
qualsiasi tensione meridionalistica è, per molti aspetti
controprova.
Lo Stato unitario si trova così a dover affrontare
contemporaneamente problemi diversi e spinte di estrema
difficoltà e complessità, rispetto alle quali l'ingresso
nell'unità monetaria europea è certamente una condizione non
trascurabile che, tuttavia, non sembra un risultato sufficiente
e, di per sé decisivo.
C'è, poi ed inoltre, da considerare il secondo elemento
costitutivo del malessere: la perdita di identità della persona
all'interno dell'attuale modello di stato e di Welfare State.
Tale modello, infatti, si basa sul principio di una tutela
centralizzata ed uniformatrice dei bisogni dei singoli
individui, i quali, in tal modo, diventano, e, quel che più
conta, finiscono per sentirsi, un numero dentro il meccanismo
dell'apparato: una pratica burocratica, un'entità anonima e
fungibile.
D'altra parte questo fenomeno di perdita dell'identità e di
progressivo generale appiattimento è indotto altresì dal diffuso
consumismo o, meglio, dall'omologazione dei consumi, dei gusti,
dei comportamenti in una condizione che conosce la scomparsa di
grandi tensioni ideali e morali, l'assenza di idee unificanti,
il prevalere del materialismo del vivere.
Perfino certi drammatici e, purtroppo non infrequenti, fatti di
cronaca (i sassi dai cavalcavie sulle strade, i giochi
pericolosi sui binari ferroviari, le varie forme di gare
rischiose tipo roulette russa, per altri versi lo stesso consumo
delle droghe, gli atti di violenza, le bravate, l'invenzione di
originalità ad ogni costo) potrebbero essere manifestazione
insieme di un grande disagio interiore e di una ricerca, a
qualsiasi prezzo, di una qualche identificazione: un bisogno di
affermarsi comunque, di essere
riconoscibili e riconosciuti, di sfuggire al generale
appiattimento.
Il ripiegarsi allora sul proprio particolare esaltandolo, la
contrapposizione con qualcuno o qualcosa o con il resto,
l'adesione a battaglie di vera o presunta diversità etnica, di
rottura degli assetti attuali, di localismo, o anche di
indipendentismo, diventano così facili e quasi consequenziali,
convinti anche se acritici, sinceramente disponibili ad
entusiasmi perfino accesi e tuttavia completamente privi sia di
adeguate analisi che di un qualsiasi vero e nuovo progetto
culturale. Per quanto si possa denunciare i limiti e le
insufficienze di tutti questi fenomeni, resta comunque il fatto
che essi esprimono un dato reale, un malessere profondo e
mettono in qualche modo in crisi i modelli istituzionali
precedenti.
HI. Inevitabilità ed inadeguatezza del federalismo -
Una possibile risposta: lacomunità delle comunità - Democrazia
capillare e pluralismo istituzionale -Il ruolo residuo della
Struttura Intermedia - Piccola comunità e Comunità
internazionale - Dubbi sulle privatizzazioni -
Separazione tra amministrazione e gestione - Impresa e
democrazia industriale: ipotesi problematiche -Carattere
provocatorio delle considerazioni svolte.
Ritorna per le ragioni anzi dette l'interrogativo già posto
precedentemente. Viene da chiedersi infatti se sia più possibile
affrontare e risolvere tutti i grandi problemi che emergono e
rimuovere le radici del malessere, senza una radicale
trasformazione del modello statuale.
Non a caso, del resto, è ormai da tempo che, un po' da tutte le
parti, si parla e anzi già si procede alla formulazione di
ipotesi e di testi di riforme istituzionali ed, insieme, di
riordino del Welfare State.
Una chiara intuizione di questa necessità, ed anzi qualcosa di
più di un'intuizione si ebbe in Italia, dal 1982 in poi fin
quasi al termine degli anni '80. Le analisi e le proposte allora
più volte avanzate, le indicazioni e gli inviti espressi anche
in precisi documenti politici, incontrarono tuttavia difficoltà,
resistenze ed incomprensioni, che non consentirono di realizzare
un processo di autorinnovamento e di riforme che, forse, in quel
tempo, avrebbero potuto più facilmente e tempestivamente
corrispondere a quella condizione critica, di cui si
denunciavano abbastanza puntualmente i segni, già allora
riconoscibili.
Ha, almeno in questa sede, poca importanza cogliere le ragioni,
le eventuali debolezze ed insufficienze intrinseche o,
viceversa, le sordità esterne, che non consentirono a quelle
intuizioni ed a quell'impegno di avere esito efficace e
positivo. Quello che conta è che purtroppo quel tentativo non
riuscì e che tutti i problemi allora posti, e molte delle
indicazioni allora avanzate, restano oggi sul tappeto pressoché
intatti ed, anzi, aggravati da oltre dieci anni di ritardo.
Bisogna considerare ora in qual modo si pongano attualmente le
grandi questioni che, per buona parte, erano già poste fin da
allora.
Rispetto all'esigenza di una profonda riforma degli assetti
istituzionali sembra prevalere un indirizzo che tende a dare
sostanzialmente una risposta, nella chiave di una organizzazione
federalistica dello Stato.
Questo si può comprendere e, per certi aspetti, appare pressoché
inevitabile.
Sia consentito, tuttavia, di avanzare il dubbio che, di per sé,
un qualsiasi federalismo non basta. Se la crisi dovesse
investire, come si è detto, il modello stesso dello Stato
tradizionale, essa non si risolverebbe e non si potrebbe
risolvere, dividendolo in tanti sottomodelli, senza cambiarne
radicalmente l'impostazione. In tal caso il federalismo potrebbe
apparire più il portato di una frettolosa risposta inseguitrice,
che non una risposta reale ed adeguata alla crisi dello Stato.
Il dubbio è che tale crisi possa essere già andata oltre
l'esigenza di un riordino, anche se radicale, e di un ampio
decentramento autonomistico.
Forse la risposta vera alla condizione attuale non sta nel
creare un qualsiasi aspetto federalistico, come non sta nella
separazione e creazione di Stati indipendenti. Forse tutte le
strutture intermedie, o di mediazione non sono più sufficienti e
bisognerebbe andare oltre: puntare cioè direttamente sulle
singole comunità creando intorno ad esse ampi e autentici spazi
di autonomia4.
Ma comunità non sono solo i municipi ed il discorso fatto non
dovrebbe limitarsi ad essi. Comunità è la scuola, ogni singola
scuola, come ogni singola ASL e forse addirittura ogni singola
impresa. Più in generale ogni reale Comunità di interessi
potrebbe, e dovrebbe essere, il soggetto portante di una nuova
articolazione dell'ordinamento.
Dentro ogni Comunità di appartenenza, tra l'altro, il singolo
individuo è riconoscibile ed è riconosciuto, ha una sua identità
di persona, con le proprie caratteristiche, che solo risultano e
si riconoscono nella relazione con i vicini, anch'essi
riconoscibili e conosciuti.
Nella Comunità inoltre gli stessi bisogni non costituiscono
un'astrazione, ma un dato concreto, colto nella sua realtà, il
che vuol dire anche nella sua peculiarità rispetto agli altri.
Del resto, se ci si riferisce a quella prima comunità naturale
che è la famiglia, si può, ad esempio, facilmente riconoscere
che, se in una famiglia ci sono più figli ed uno di essi non va
tanto bene a scuola, il padre di famiglia, o la famiglia nel suo
insieme, curerà quest'ultimo e forse gli farà fare lezioni
private da un insegnante.
Non chiamerà tanti insegnanti per quanti sono i figli, magari in
nome di un astratto principio di eguaglianza: tutelerà invece il
bisogno vero, lì dove esiste. Questo è dunque possibile nella
Comunità, nulla toglie alla tutela effettiva dei bisogni e,
realizzando l'equità concreta, invece della giustizia astratta,
produce anche un contenimento della spesa.
Lo stesso riordino del Welfare State potrebbe forse
trovare allora in un'articolazione pluralistica e diffusa,
Comunità per Comunità lo strumento principale che, senza nulla
togliere alle grandi conquiste del riformismo, consente di
evitare sprechi, lungaggini, burocratizzazioni.
Naturalmente tutto ciò esigerebbe il massimo controllo
democratico possibile, nella gestione e nella vita di ogni
Comunità e quindi l'elettività del governo di ciascuna di esse.
Esigerebbe cioè una diffusione capillare della democrazia e
quindi una riforma istituzionale che non si limiti a ridurre il
potere centrale per distribuirlo, tra altri poteri centrali e
centralizzati, sia pure per territori più limitati, ma
direttamente si articoli in un ampio e diffuso pluralismo di
istituzioni e di autonomie5.
Alle strutture intermedie ed in particolare a quella nazionale,
la cui permanente legittimità deriva dall'identità della lingua
e della cultura di un popolo, resterebbero ovviamente alcuni
compiti generali, che le singole Comunità, da sole, non
potrebbero realizzare. Resterebbe altresì una funzione di
coordinamento, capace di impedire ed insieme comporre il
possibile contrasto tra le Comunità, di assicurare uno spazio di
solidarietà delle più forti verso le più deboli, di mediare il
rapporto con la più ampia Comunità europea ed internazionale.
Lo Stato, in tal modo, verrebbe per così dire a definirsi come
una Confederazione di Autonomie o, per citare una frase di Henry
Brugmans, come una "Comunità di Comunità"6.
Se questo riguarda immediatamente il vecchio Stato nazionale,
potrebbe anche segnare una linea di movimento più ampia,
destinata ad interessare le Comunità più alte e, per prima
quella dell'Europa, superando così, come linea di indirizzo, sia
l'idea di Europa puramente contabile, sia quella di una Europa
degli Stati, per tendere a costruire l'Europa delle Comunità.
Come si è già avuto modo di ricordare, nel mondo di oggi si
notano due spinte, egualmente vere ed apparentemente
contraddittorie. La spinta della crescente
internazionalizzazione di tutti i rapporti, e non solo
dell'economia, e la spinta del localismo e del particolarismo.
Forse il compito di una nuova cultura politica sta, fra l'altro,
anche qui: non solo nel prendere atto dell'irreversibilità di
entrambi le spinte, ma nel realizzare proprio su questo punto,
una mediazione e composizione possibile,
che salvaguardi insieme l'obiettivo alto di una grande
unificazione e solidarietà mondiale, ed il rispetto scrupoloso
ed attento di ogni peculiarità, di ogni etnia, del genio proprio
di ogni ambiente e di ogni territorio, in una parola di ogni
autonomia e libertà.
Conviene ora, sia pur rapidamente, riflettere su un altro
aspetto riguardanteuna radicale riforma dell'ordinamento.
Nel dibattito attuale due sono i punti che sono apparsi emergere
sugli altri: il federalismo e le privatizzazioni. Del primo si è
già detto.
Sulle seconde sembra almeno legittimo avanzare qualche dubbio.
C'è da chiedersi infatti se sia davvero corrispondente alle
domande più profonde del tempo che si vive, la dismissione
dell'impegno pubblico almeno per quanto riguarda le ed. grandi
reti che, proprio perché tali, investono un territorio molto più
vasto di ogni singola Comunità. Ciò soprattutto riguarda
l'energia, i trasporti, l'acqua.
Naturalmente è opportuno distinguere il momento politico delle
scelte e della programmazione da quello puramente gestionale.
Che la gestione possa ed, anzi, debba essere privata, o comunque
imprenditoriale, sembra del tutto comprensibile. Ma è difficile
ritenere opportuno che la politica delle grandi reti sia
lasciata a logiche privatistiche.
Questo richiamo però consente di introdurre un discorso più
generale di riforma, riguardante la distinzione ed anzi la
separazione tra il momento dell'amministrazione, che è politico
e proprio dell'Esecutivo, e quello della gestione. La riforma
del vecchio modello istituzionale probabilmente dovrebbe
investire sia, ed innanzi tutto, la dimensione, per così dire,
orizzontale, creando ampie e diffuse autonomie; sia la
dimensione verticale, cui si riferisce la tradizionale
distinzione tra potere legislativo,
esecutivo e giudiziario. Anche nell'ambito di tali funzioni o
poteri potrebbe e, forse, dovrebbe realizzarsi un'articolazione
pluralistica, una più chiara e netta distinzione tra vari
momenti e vari compiti. Un'ampia ed, anche fin troppo,
appassionata discussione si è aperta, in questo senso, per
quanto riguarda la funzione giudiziaria ed il rapporto
tra il ruolo inquirente e l'attività propriamente giudicante,
anche in conseguenza dell'assetto accusatorio del nuovo Codice
di Procedura Penale. Ma il problema riguarda anche il Parlamento
e la distinzione o, forse, separatezza tra l'attività
legislativa vera e propria e quella di controllo.
Riguarda soprattutto e l'Esecutivo e la separazione come appena
detto, tra Amministrazione e Gestione.
Sia consentito, al riguardo, di ricordare come a suo tempo
fossero state avanzate alcune proposte, che purtroppo caddero
nel vuoto, su un punto importante di questa separazione: quello
che riguarda la gestione degli appalti di opere e di servizi. Fu
proposto allora che tale gestione venisse sottratta, a tutti i
livelli, quindi anche nelle singole Comunità, alla
responsabilità politica, per essere affidata direttamente alla
società civile, tramite le organizzazioni professionali
competenti, con la presenza eventualmente di magistrati
amministrativi ed attraverso organismi elettivi, susseguentesi
a non lunga distanza di tempo. Anche qui allora si
trattava e si tratterebbe di guardare alle comunità di
interessi, alle organizzazioni naturali e spontanee che la
società esprime e di ridurre la politica al compito alto
dell'amministrazione, sottraendole un impegno gestionale, fra
l'altro sempre rischioso. In ogni caso, anche su questo terreno,
si tratterebbe di realizzare un più articolato e ricco
pluralismo istituzionale.
I limiti stessi, già fin troppo allargati, del presente lavoro,
non consentono ulteriori e più dettagliati approfondimenti. Vale
tuttavia la pena di aggiungere un'ultima riflessione su
quell'aspetto particolare, già prima accennato, che riguarda
l'impresa.
Qui probabilmente si tratterebbe di sperimentare e lasciare alla
spontaneità delle forze in gioco l'eventuale costituirsi
dell'impresa come comunità. Nel corso degli ultimi tentativi,
volti a proporre una riforma ed una rilancio dell'impegno
meridionalistico, si propose, tra l'altro, l'idea del formarsi,
nel Mezzogiorno, di associazioni o cooperative di giovani
lavoratori, professionalmente ed adeguatamente formati, che
potessero offrire, a costo competitivo, il proprio lavoro, in
cambio, o nella prospettiva concordata, di una partecipazione
agli utili di impresa e/o alla gestione, almeno nelle grandi
linee della medesima.
Tale indicazione tendeva ovviamente a determinare, in tal modo,
un forte incentivo per la nascita di nuove intraprese nel
Mezzogiorno, risolvendo, con spontanee e volontarie scelte dal
basso, l'antica discussione sul ripristino o meno delle ed.
"gabbie salariali".
Al di là, tuttavia, di questa specifica indicazione, che pure
trovò allora qualche attenzione, almeno in una parte del
sindacato, lasciare, sia pure in via sperimentale, alla
spontaneità dal basso, le scelte sul costo del lavoro, sulla
partecipazione agli utili, sull'organizzazione interna
dell'impresa, anche per renderla più competitiva, potrebbe
essere l'occasione e lo strumento per sperimentare forme di
democrazia industriale.
Recentemente è stata presentata in Parlamento una iniziativa
legislativa di Alleanza Nazionale, che sembra muoversi in questa
stessa direzione.
La cosa non sorprende perché nell'antico retroterra culturale
della destra politica italiana c'è, fra tante cose anche
contrastanti, una qualche attenzione verso le concrete comunità
di interessi. Nello stesso fascismo italiano, che va ormai
esaminato in sede storica, confluirono filoni ed elementi
culturali diversi e contraddittori: l'irrazionalismo, il
volontarismo, come l'hegelismo. In questo coacervo di tendenze
varie, ed anche eterogenee, affiorò ad un certo momento la ed.
dottrina del corporativismo, che trovò negli scritti di Ugo
Spirito una qualche significativa dignità culturale. Tuttavia il
corporativismo, assunto all'interno di una concezione
totalitaria e di uno Stato dittatoriale, fatalmente si configurò
come un fatto posticcio, una sovrapposizione imposta,
artificiosa e burocratica. L'attenzione verso ogni concreta
comunità di interessi esige invece il massimo di articolazione
democratica e di tutela della spontaneità dei fatti.
Ma tornando all'ipotesi di sperimentare forme di democrazia
industriale bisogna ovviamente rendersi conto che una siffatta
questione ha una sua oggettiva complessità e, per così dire, una
sua delicatezza. Può incontrare perciò dubbi, più che legittimi,
difficoltà e resistenze. Tuttavia se la crisi fosse quella del
modello centrale e centralizzante dello Stato, potrebbero
riacquistare attualità alcune antiche, tradizionali intuizione
della Cisl, nonché la tendenza al prevalere delle contrattazioni
aziendali su quella nazionale o ed. collettiva.
D'altra parte, sempre ove il presupposto della crisi dei modelli
verticistici fosse vero, tutte le strutture, le organizzazioni,
le stesse associazioni che si modellano sull'articolazione
verticale e centralistica dell'ordinamento, sarebbero fatalmente
destinate ad esser messe in discussione e sollecitate a qualche
ripensamento ed a qualche riorganizzazione. Ovviamente si
tratterebbe sempre di processi e non di schemi precostituiti,
definiti e certi.
Il farsi della storia costituisce sempre un processo. Non è
dunque giusto e, forse, nemmeno possibile, una volta maturata,
eventualmente, la consapevolezza della crisi di un vecchio
modello, prefigurarne dettagliatamente, quasi a tavolino, un
altro, costruito illuministicamente, dall'alto, come un
meccanismo perfettamente organizzato e compiuto.
Per lo stesso agire storico e, quindi, politico, l'importante è
individuare la direzione possibile di movimento, le linee
portanti ed essenziali di un nuovo progetto, a quello
corrispondente.
Questo vale in generale e, perciò, tutte le indicazioni sopra
avanzate, e non solo questa ultima, lo sono in modo
problematico, senza certezze e senza alcuna presunzione. Esse
andrebbero quindi assunte più che altro come provocazioni,
nascenti dal dubbio, più volte ribadito, che non sia più
possibile risolvere tutti i grandi problemi attuali, all'interno
dello schema tradizionale dell'ordinamento statuale.
In ragione di tale dubbio la rilettura della storia di un Libero
Comune d'Italia come fu Orvieto, specie nei secoli XIII e XIV ha
offerto ed offre un'occasione ed insieme un pretesto di
riflessioni di una qualche attualità e forse anche utilità.
1
Vedi più avanti le considerazioni riguardanti lo storicismo,
Hegel, Schopenauer,l'esistenzialismo, il recupero del
Trascendente.
2
L'alta inflazione, cominciata sul finire degli anni '60 ha avuto
origine, secondo l'ala
monetarista, rappresentata dal Friedman, principalmente
nell'eccesso di domanda, conseguente all'aumento dell'offerta
mondiale di moneta, derivata dal disavanzo della bilancia dei
pagamenti degli USA. Tale disavanzo avrebbe indotto un aumento
del flusso delle esportazioni verso gli USA rispetto alle
importazioni da esso. Avrebbe perciò provocato, in conseguenza
della posizione dominante degli Stati Uniti e del dollaro, quale
principale valuta di riserva, una crescita netta della domanda
effettiva nelle economie del resto del mondo.
A questa spiegazione si è contrapposta, da parte di altri
economisti, prevalentemente
inglesi e di scuola keyncsiana, quella della inflazione da
costi, che ha considerato, come origine della pressione
inflazionistica, la spinta in alto dei costi ed in particolare
dei salari.
Dalla prima teoria deriva, come logica conseguenza, la necessità
di politiche restrittive della domanda, le quali, tuttavia,
comportano, di per sé, periodi di sottoutilizzazione delle
capacità di produzione e quindi sensibile disoccupazione. Dalla
seconda teoria deriva invece la necessità di un'accentuata
politica dei redditi e di controllo dei prezzi: politica sempre
diffìcile, perché è difficile coniugarla efficacemente con la
flessibilità necessaria ad ottenere l'indispensabile consenso
sociale.
Probabilmente entrambe le contrapposte spiegazioni contengono
elementi di verità.In ogni caso, nella grande complessità
dell'economia moderna appare pressoché impossibile contare
sull'utilizzazione di un solo strumento di politica economica.
3
Quest'ultima, nel ventennio precedente (anni '50-'60) era
finalmente uscita dalla fase dell'analisi teorica e della
declamazione, propria di tutti i periodi precedenti dello Stato
unitario, ed aveva formato oggetto di un impegno puntuale,
sufficientemente organico ed incisivo, portato avanti con la
nascita e l'azione della Cassa per il Mezzogiorno. Acquedotti,
bacini idrici, impianti di irrigazione, elettrificazioni,
strade, scuole, ospedali, strutture ricettive, rimossero allora
una condizione secolare di arretratezza, di miseria, di assenza
delle condizioni stesse di un'elementare vita civile. Vi furono
certamente anche errori ma solo chi ignora e vuole ignorare le
condizioni reali di partenza, può negare o sminuire il valore e
la portata dell'impegno attuato in quegli anni. Si può dire anzi
che alla fine degli anni '60 si erano create nel Mezzogiorno
d'Italia le premesse del superamento dell'antica arretratezza e
dell'avvicinamento anche, per così dire fisico, al resto
d'Italia.
Si era perciò, e certo non casualmente, ma conseguentemente,
anche impostato e attivato un processo di industrializzazione di
notevole dimensione, sia attraverso l'intervento diretto
dell'impresa pubblica sia incentivando l'impresa privata.
Processo che, abbastanza comprensibilmente riguardò tuttavia
prevalentemente la ed. industria di base, sia nel settore
chimico sia nel settore siderurgico. Successivamente, in
proposito, si parlò e forse non del tutto a torto di
cattedrali nel deserto. Ma bisogna dire, innanzi tutto, che
questa fu una considerazione postuma ed, in ogni caso, essa ha
avuto ed ha il limiti di una valutazione successiva
all'insorgere della crisi generale dell'industria di base.
Niente consente di negare che, in un contesto internazionale che
rosse rimasto sufficientemente coerente a quello in cui le
previsioni e le decisioni di allora maturarono, la nascita di
grandi impianti di base avrebbe potuto suscitare, a valle ed
intorno, altre intraprese di trasformazione, di maggior valore
aggiunto, stimolando in tal modo la crescita di un tessuto
industriale più vasto e più diffuso. L'intervento straordinario,
non meno della costruzione del Welfare State, e della
riforma agraria è stato uno dei momenti importanti e positivi,
della grande stagione riformatrice dello Stato democratico,
della profonda trasformazione e del grande progresso
dell'Italia. Gli eventi internazionali hanno poi finito per
rovesciare le tendenze precedenti e per spegnerne moiri
entusiasmi. Le profonde modifiche intervenute nel quadro
internazionale hanno posto, allora, a tutta l'Italia problemi,
sfide, rischi nuovi e diversi, che ben presto, quasi fatalmente,
hanno portato ad un indebolimento ed anzi, determinato ragioni
anche interne di una interruzione della politica
meridionalistica. Gli interessi forti del Paese furono, per così
dire portati a realizzare una qualche convergenza tra di loro, a
tutela e difesa delle proprie condizioni e, con ciò stesso
segnarono un atteggiamento oggettivo ed insieme psicologico, di
disattenzione verso gli interessi più deboli e quindi verso il
Mezzogiorno.
Emerse e prevalse allora l'esigenza di assicurare produttività,
competitività, efficienza
all'apparato produrtivo esistente trascurando o, comunque,
posponendo le esigenze
diverse di un apparato i n fieri.
Non a caso in quel tempo, da allora e per molti anni, la Cassa
per il Mezzogiorno sopravvisse con proroghe modeste e di breve
periodo, che non consentivano più un adeguato respiro
programmatorio.
Una nuova legge per il Mezzogiorno si ebbe solo molti anni dopo,
quando lo slancio
iniziale si era in qualche modo interrotto e, peraltro, in un
tempo in cui era ormai nata e si era consolidata la realtà delle
Regioni. La nuova legge non potè non tenerne conto, sicché si
diede vita ad un complesso meccanismo per l'elaborazione di
piani triennali e di singoli piani annuali ed esecutivi. Un
meccanismo che in parte, per intrinseca farraginosità, in parte
per l'inadeguatezza delle strutture regionali, nate da un tempo
tutto sommato breve, in parte infine per l'indebolimento di
quelle centrali, ove la lunga parentesi di fiacca aveva
probabilmente spento antichi entusiasmi e provocato la
fuoriuscita di alte professionalità, si trasformò, di fatto, in
un andirivieni lungo e lento di pratiche, di richieste, di
valutazioni, prima che si giungesse infine alle decisioni.
Nonostante ciò vennero impostate e realizzate iniziative
importanti come, in particolare, la nuova legge sulla ed.
imprenditoria giovanile.
Complessivamente però l'intervento straotdinario apparve
disperdersi, spesso in tanti piccoli rivoli, senza nemmeno
giungere sempre ad opere definite e concluse. Più tardi, proprio
alla fine degli anni '80 ci fu un tentativo di modificare questo
stato di cose, concentrando su pochi progetti strategici le
poche risorse disponibili e lasciando direttamente alle Regioni,
senza l'andirivieni burocratico sopra accennato, la
responsabilità delle scelte per una data quota di risorse ad
esse direttamente erogate: tentativo che ebbe anche la
consacrazione di un documento approvato dal Governo e della
impostazione dell'ultimo piano triennale approvato, alla fine,
anche dalle Regioni. Fu, tuttavia, un tentativo rapidamente
interrotto dal succedersi degli accadimenti politici e,
probabilmente fu anche un tentativo tardivo, che non riusci, e
forse non poteva riuscire, a trovate adeguato consenso ed a
rianimare una tensione meridionalistica, ormai pressoché spenta.
Stava maturando infatti quella più generale crisi politici che
in poco tempo travolse
in Italia tante cose e, tra esse, la stessa sopravvivenza di un
intervento straordinario.
4
Non appare casuale e sembra muoversi in qualche modo in questa
direzione, il fatto che molti sindaci di grandi città (da Napoli
a Venezia etc.) hanno posto con forza l'accento sull'importanza
delle autonomie comunali. Si potrebbe anzi forse ritenere che lo
stesso successo elettorale recente di tali sindaci, certamente
legato anche alla validità della loro gestione ed alle capacità
dimostrate, esprima pur esso, tuttavia, un'esigenza profonda che
muove dal basso, di affermazione delle municipalità e del
bisogno di identità che in esse, in qualche modo, si appaga.
Anche altrove, per altro verso ed in modo certo diverso e
preoccupante, si è visto l'insorgere di segnali e di
manifestazioni che, probabilmente, non possono liquidarsi come
meramente folkloristiche, e rivelano anch'esse una qualche
tendenza verso autonomie più circoscritte e, per cosi dire, più
naturali. Certo si tratta di fenomeni che possono, ed anche
rapidamente, degenerare. Ma i pericoli non si affrontano solo
denunciandoli e nemmeno limitandosi, sia pure doverosamente a
contrastarli. C'è anche una risposta che bisogna dare non alle
manifestazioni, ma alle ragioni profonde che le alimentano e che
possono suscitare intorno a quelle un alone di simpatie e pure
anche di consenso.
5
Questa visione pluralistica, che investe la stessa articolazione
dell'ordinamento, fu,
come si è evidenziato nel testo, una caratteristica dei Liberi
Comuni medioevali, intrinsecamente
legata alla concezione della Trascendenza.
Come si vedrà meglio in seguito una fede trascendente suggerisce
un approccio
dell'impegno politico nella direzione della democrazia, della
difesa ed espansione delle
libertà, del continuo rinnovamento e della consapevolezza che la
gestione necessariamente
assume un carattere di centralità e moderazione.
Conviene precisare, tuttavia, che la moderazione non va e non
può essere confusa
con la conservazione. Moderazione è solo il metodo della
mediazione tra tendenze contrastanti
e non può, per ciò stesso, identificarsi con nessuna di esse,
tanto meno quindi con la mera conservazione dell'esistente.
Moderazione semmai è sinonimo, non già di
conservazione, bensì di quella tolleranza, che è il volto
intellettuale della fondamentale virtù cristiana dell'umiltà e,
come questa, necessariamente deriva dalla coscienza
dell'insufficienza della ragione umana.
Chi ha una fede consapevole, inoltre, sa di potere ricavare da
essa alcuni principi
ispiratori, non soluzioni politiche puntuali, definite e
precise. Le soluzioni per così dire tecniche non gli sono
offerte dalla fede di per sé; ma sono il frutto della propria
ricerca e di una elaborazione contingente. Ne deriva che essi
vanno assunte come responsabilità, proprie e laiche, di
cittadini. Ma c'è un'altra conseguenza, perché tutto questo
significa che in politica non si può avere un approccio
ideologico. La fede non offre un'ideologia, anzi rende
consapevoli dell'impossibilità ed insieme astrattezza di
qualsiasi ideologia. Tuttavia l'approccio alla politica non è e
non può essere nemmeno puramente empirico, perché ci sono
principi eterni, assoluti, sempre validi da cui non si può
prescindere. Per chi ha fede quindi, l'approccio politico
consiste, da un lato nel continuo e problematico sforzo di
leggere la storia nel suo accadere e nei suoi cambiamenti, di
confrontarsi quindi con i bisogni e le istanze che la muovono,
di elaborare le risposte possibili; dall'altro, consiste nel
rifarsi sempre a quei principi eterni, quasi fari che illuminano
dall'alto il movimento, per ricavarne non già soluzioni
tecniche, definite, ma, criteri di orientamento.
In questo senso, perciò l'impegno è quello di ricercare sempre e
di elaborare, volta a volta, la sintesi possibile tra principi
eterni e realtà mutevoli.
Nel formularla non solo si può sbagliare e spesso si sbaglia,
ma, in ogni caso, non si raggiunge mai una verità certa che, in
quanto tale, si possa imporre. Ma se ogni soluzione politica, in
quanto afferente sempre alla mutevolezza delle cose umane, è di
per sé imperfetta, inevitabilmente non possono essere ignorate
anche le altre voci, le altre proposte o indicazioni che a quel
mutare delle cose si riferiscono e da esso pure, in qualche modo
derivano. Nasce da ciò la necessità dell'ascolto,
dell'attenzione, del dialogo e perciò, ancora una volta, sempre
della tolleranza. Né l'attenzione verso ciò che è diverso e
perfino contrapposto può essere monovalente. Essa va rivolta a
tutte le diversità, esige il rispetto ed anzi il riconoscimento
non solo della pluralità delle idee, dei movimenti, delle
opinioni ma anche delle comunità, delle autonomie, delle
peculiarità di ogni zona, settore o territorio. Esige il
rispetto e la salvaguardia del pluralismo, cosi delle idee come
delle istituzioni. Quanto più anzi si ha coscienza che
l'ordinamento, qualsiasi ordinamento, e quindi anche quello
statuale non è un valore in sé, ma piuttosto un semplice
strumento di organizzazione della convivenza civile e di
garanzia delle libertà, tanto più si evidenzia l'esigenza del
massimo pluralismo istituzionale possibile.
Non a caso, nel testo si è avuto modo di sottolineare come il
modello dello Stato centrale ed accentratore, che dall'alto
tutto dirige ed a tutto provvede, attraverso un massiccio
apparato burocratico, contiene almeno il rischio di essere
ritenuto un valore in sé e quindi di divenire strumento idoneo
di pretese assolutistiche. La consapevolezza del limite della
politica, e della necessità di una ricerca continua di cultura
politica, appare più prossima perciò e, forse, più coerente ad
un diverso modello di Stato.
6
Cfr. H. BRUGMANS, Panorama del pensiero federalista.
Comunità, Milano I960.
L'opera del Brugmans, sostenitore del ed. federalismo integrale
appare di grande interesse e suggestione anche se è datata ed,
in certa misura, un po' troppo semplificante.
Essa costituisce, pur sempre, un utile strumento di
riconoscimento e di lettura di tutto un filone di pensiero,
autonomistico e federalistico che, tra l'altro, testimonia come
le indicazioni sopra problematicamente avanzate, non
costituiscano niente di originale ed anzi in qualche modo si
rifacciano a quella che, nella prefazione del libro, viene
considerata "una costante della storia dell'Ottocento e del
Novecento che continuamente si contrappone alla costante del
centralismo" e costituisce, secondo l'espressione del Brugmans,
"il pensiero vinto che [...] tuttavia sempre si prende le sue
rivincite'.
In questo filone, in modo vario, con motivazioni ideali anche
diverse, si collocano intuizioni, denunce, analisi ed
indicazioni che vanno dal l'roudhomme a W. Lipman a S. Weil, al
personalismo di E. Mounier, J. Maritain, De Rougemont, al
Movimento di Comunità di Adriano Olivetti, etc...